P. Boylan (2002). "Facoltà
tecnico-scientifiche e facoltà umanistiche: tipologia
dell'insegnamento linguistico e contributo del CLA", in: C.
Vergaro (a cura di), Verso
quale CLA? La ridefinizione dei ruoli dei Centri Linguistici d'Ateneo
nella prospettiva dei nuovi ordinamenti didattici,*
Napoli:
ESI (ISBN
88-495-0569-8)
*Atti
dell'omonimo Seminario Nazionale, Perugia, 8-9 giugno
2001
____________________________________________________________________
Facoltà
tecnico-scientifiche e facoltà umanistiche:
tipologia
dell'insegnamento linguistico e contributo del CLA
Patrick
Boylan
Università
di Roma Tre
Credo
sia molto significativo che il futuro Centro Linguistico di Perugia
sorga in un padiglione della Facoltà di Medicina. Ogni
anno, infatti, confluiscono nelle facoltà perugine, come nella
facoltà universitarie di tutta l'Italia, migliaia di matricole
che non hanno imparato bene le lingue straniere a scuola, ma che
dovranno leggere testi scientifici in lingua per un esame o per la
tesi. Spetta, dunque, al Centro Linguistico fungere da
"infermeria", con il compito di applicare i cerotti del
caso e di risistemare gli interventi maldestri subiti da queste
matricole a scuola, da parte di insegnanti di lingue ben intenzionati
ma non sempre adeguatamente preparati per insegnare le lingue vive in
quanto vive.
Con
queste osservazioni non intendo affatto addossare colpe alla
categoria degli insegnanti, né voglio disconoscere i grandi
meriti dei moltissimi docenti di lingue che operano nelle scuole oggi
e che, talvolta a spese proprie, hanno saputo aggiornarsi dopo la
laurea e la specializzazione. I loro meriti, però, non
ci devono far perdere di vista il dilemma della maggioranza degli
insegnanti.
I
dati ministeriali sono eloquenti al riguardo. Ci dicono,
infatti, che in media gli alunni della Scuola italiana conoscono le
lingue molto meno dei loro coetanei del resto d'Europa. Non
solo, ma che buona parte degli studenti italiani arrivati alla
maturità è meno disposta ad imparare le lingue di
quanto non lo fosse all'inizio della carriera scolastica. In
altre parole, la Scuola è servita più che altro a far
perdere la voglia d'imparare le lingue. Evidentemente qualcosa
non va nel processo formativo.
Quale soluzione ha proposto l'università in quest'ultimo
ventennio? Risale infatti a 20 anni fa il quesito che il Consiglio
Universitario Nazionale (CUN) ha posto al mondo accademico sui mezzi
da adottare (tra cui la creazione di "centri linguistici
interfacolta'") per colmare le carenze linguistiche degli
studenti universitari che a scuola non hanno imparato bene le lingue.
Elaborai anch'io una risposta al quesito del CUN, sotto forma di un
opuscolo che, ritenuto troppo controverso all'epoca, e' rimasto
inedito.[Cliccare qui>
1] Vorrei riproporvi nel mio intervento di oggi
le analisi e le proposte elaborate allora in quanto le giudico
attualissime ancora oggi.
Quale
soluzione, dunque, hanno prospettato le università in tutti
questi anni? Purtroppo, la soluzione non è stata
quella di riformare realmente i corsi di laurea in lingue per
consentire agli studenti d'apprendere non solo le letterature
straniere in quanto patrimonio storico da conservare, ma anche le
lingue straniere in quanto mezzi vivi di espressione da
interiorizzare.
Sia
ben chiaro: apprendere le lingue in quanto vive non vuol dire
banalmente imparare a parlarle, come si fa nelle scuole commerciali.
Vuol dire molto di più: pervenire ad interiorizzarle come
microcosmi culturali. Si tratta dunque di un sapere che è
diverso dalla semplice capacità di pronunciare, scrivere ed
interpretare correttamente brani in lingua — cose che possiamo
imparare a fare addirittura in una lingua morta come il Latino o il
Greco. Sapere una lingua in quanto viva significa invece
andare ben oltre questi traguardi scolastici. Significa sapersi
relazionare con parlanti madrelingua, a tu per tu, dall'interno
del loro mondo linguistico-culturale: saper cogliere,
identificare, interiorizzare e riutilizzare i loro schemi
interpretativi ed espressivi (cioè, i loro modi di esprimersi
che traducono un particolare modo di essere, un particolare universo
condiviso di valori vissuti che abbiamo chiamato microcosmo
culturale); saper co-elaborare, con loro, regole
d'interpretazione condivise, mediante una trasformazione del sé,
per creare un terreno d'intesa verificabile empiricamente; in una
parola, saper fare – in lingua – l'etnolinguista, il
maieuta, l'osservatore partecipante e, infine, il parlante
interculturale.[Cliccare qui> 2]
Nella
maggior parte delle università, invece, le lingue vive vengono
ancora insegnate come se fossero lingue morte: cioè gli
studenti imparano la pronuncia, la grammatica, e la storia della
lingua; imparano ad interpretare e ad inquadrare storicamente brani
letterari; ma non imparano a relazionarsi in lingua, a cogliere ed
interiorizzare la forma mentis di un interlocutore, a verificare
sperimentalmente in situ il significato di una parola, a
vivere l'atto espressivo nella sua unitarietà materiale
(verbale, prosodica, gestuale...) ed esistenziale (come espressione
di valori vissuti condivisi). Pertanto questi studenti, pur
esprimendosi in frasi grammaticalmente corrette e pragmaticamente
appropriate, non sempre s'intendono con i loro interlocutori
stranieri; non sempre risultano chiari e convincenti; non sempre
colgono il senso di ciò che viene comunicato loro attraverso
sottili intrecci di parole, effetti prosodici ed espressività
non verbale.
Questi
studenti poi divengono i futuri insegnanti di lingue nella Scuola.
Ma dal momento che non vivono le lingue come habitus mentale, non
sanno trasmetterle come tale ai loro alunni. Anzi, essendo
stati abituati dalle lezioni universitarie a considerare le lingue
come oggetti da analizzare soltanto, come forme platoniche separate
da qualsiasi soggettività culturale propria o altrui,
trasmettano ai loro alunni questa visione da entomologo della
comunicazione umana. Non sorprende, dunque, che la maggior
parte dei loro alunni, con l'età e gli interessi che hanno,
perdono subito la voglia d'imparare le lingue. Che peccato,
potevano sentirle come risorsa per meglio capire e vivere il mondo!
Essere
competenti nelle lingue vive in quanto vive presuppone dunque
aver percorso un processo di trasformazione del sé che
si appoggia su insegnamenti antropologici, etnografici,
psicolinguistici e filosofici (l'epistemologia, l'ermeneutica).
E' un insegnamento che nulla toglie alla dignità delle scienze
filologiche e linguistiche descrittive e tanto meno alla necessità
di parlare correttamente anche dal punto di vista grammaticale quando
si usa una lingua straniera. Semplicemente... è un'altra
cosa. Per insegnare in questa nuova ottica non è
necessario essere di madrelingua straniera. Anzi, lungo tutta
la penisola – all'Università come nella Scuola –
questa impostazione viene già realizzata da qualche docente
italiano che non cerca di proporsi come parlante perfetto (del resto,
ci sono gli audiovisivi quando servono modelli da assimilare), bensì
come il Virgilio di Dante: egli si propone, cioè, come guida
capace di accompagnare i propri studenti con successo attraverso un
mondo affascinante che, pian piano, li trasformerà –
come egli stesso è stato trasformato nel percorrere con
successo questo cammino da giovane.
E'
chiaro, dunque, che riformare le facoltà di lingue per fare in
modo che le lingue vive vengano finalmente insegnate in quanto
vive, non presuppone l'accantonamento degli insegnamenti
descrittivo-letterari. Richiede semplicemente una diversa definizione
delle materie da considerare fondamentali e delle materie da
considerare complementari e, quindi, una diversa politica di
reclutamento dei docenti e dei ricercatori.
Certo,
dire "semplicemente" può far sorridere: è ben
nota la difficoltà di far rimettere in discussione la politica
di reclutamento in qualsiasi
facoltà universitaria. Nel caso del settore lingue, è
stato forse lo scoglio principale contro il quale si sono urtati e
affondati i numerosi tentativi di riforma in questi ultimi 20 anni.
Ed è proprio per via di questi fallimenti che la formazione
universitaria in lingue risulta, se non formalmente, per lo meno
sostanzialmente identica a quella dei primi corsi di laurea in lingue
avviati mezzo secolo fa.
In
che cosa consiste questa formazione tradizionale? Come abbiamo
appena precisato, consiste nello studio delle lingue vive con gli
stessi strumenti usati per lo studio delle lingue morte – anzi,
con gli stessi strumenti ideati 22 secoli fa dai grammatici
alessandrini per recuperare il patrimonio omerico, ossia l'analisi
grammaticale e l'analisi testuale.[Cliccare
qui> 3] Alcune università offrono anche
insegnamenti di sociolinguistica o di linguistica applicata che
forniscono, accanto agli strumenti filologici, alcuni mezzi utili per
capire sincronicamente interazioni in lingua. Ma in nessun
corso di laurea in lingue straniere viene privilegiato l'insegnamento
di quegli strumenti antropologici, etnografici, psicolinguistici e
filosofici richiesti per poter interiorizzare consapevolmente (come
per poter indagare scientificamente) le lingue vive in quanto
tali. Né vengono privilegiate le forme non
cattedratiche d'insegnamento previste dai nuovi ordinamenti, in
particolare lo studio assistito, il laboratorio in presenza, il
tirocinio.
Ecco,
dunque, la causa primaria delle carenze culturali degli insegnanti di
lingue nella Scuola: hanno avuto come modello, sia nelle aule
universitarie che nelle scuole di specializzazione, insegnamenti
quasi esclusivamente descrittivi nei contenuti e cattedratici nella
forma.
Ma
se i corsi di laurea in lingue non hanno voluto rimuovere dalla
radice il problema dell'impreparazione linguistica delle matricole,
valorizzando lo studio delle lingue in quanto vive, quale
soluzione hanno prospettato?
Si
intravede già la risposta nel documento CNLLS di 20 anni fa:
la creazione di Centri Linguistici con la funzione di "infermerie".
Non centri di ricerca e di didattica, bensì semplici "centri
di servizi", cioè strutture d'appoggio relegate
ai margini dell'attività vera e propria dell'università
e prive per statuto di un corpo docente interno di ordinari e
associati per promuovere anche la ricerca e la sperimentazione.
E' ovvio che centri di questo tipo possono tutt'al più
"applicare cerotti", non fare interventi di fondo per
risolvere la disfunzione del sistema formativo.
Cosa
significano queste considerazioni? Forse che i centri
linguistici sono condannati a servire solo da palliativo per
consentire alle facoltà di lingue di perpetuare lo status
quo?
Per
come si presenta la situazione attuale, credo che la risposta sia
senz'altro affermativa.
So
benissimo che esistono diversi Centri Linguistici Interfacoltà
già avviati in Italia in cui, tramite stratagemmi ingegnosi,
si è riusciti ad aggirare il tacito divieto di fare ricerca o
addirittura di possedere un corpo docente di prima e di seconda
fascia. Ma queste pur lodevoli iniziative dipendono troppo
dalla volontà di singoli esponenti; nulla garantisce che, col
tempo, le nuove leve alla direzione dei Centri dedicheranno la stessa
passione e sapranno escogitare sistemi altrettanto ingegnosi per
creare un luogo dove didattica e ricerca si congiungono. I
cambiamenti devono essere strutturali per essere duraturi e,
considerando gli attuali rapporti di forza nei consessi accademici, è
facile prevedere che non verrà mai consentita la graduale
trasformazione strutturale dei Centri Linguistici in qualcosa che
somigli, per la presenza di docenti e di ricercatori stabilmente
inquadrati, ad una facoltà di lingua viva.
Ritengo,
dunque, che ci sia un solo rimedio affinché l'Italia possa
sanare la piaga aperta che l'affligge da troppo tempo, cioè la
posizione d'inferiorità linguistica in cui si trovano i suoi
rappresentanti, rispetto ai rappresentanti degli altri paesi, nei
vari incontri internazionali, siano essi scientifici, commerciali,
culturali o altro. Il rimedio è il riconoscimento
fattivo da parte delle facoltà e dei corsi di laurea in lingue
che insegnare l'assimilazione delle lingue in quanto
vive costituisce una disciplina accademica fondamentale
– per essere chiari, una disciplina da affidare essenzialmente,
non a "lettori" o ad esercitatori, bensì a
professori ordinari ed associati, come si fa in tutte le università
del mondo. Professori ordinari e associati italiani (o
stranieri se hanno i necessari titoli) capaci di fare sia ricerca
che didattica nel campo dell'assimilazione culturale delle lingue
in quanto vive.
La
partita è ancora aperta. E ritengo che la si possa
vincere, nonostante una lunga storia di riforme naufragate.
Infatti, sono ancora in fase di attuazione tre riforme fondamentali
del settore lingue i cui esiti non sembrano ancora scontati (ci
tornerò sopra nella seconda parte di questo intervento) e che,
se attuate bene, consentiranno ai Centri Linguistici, con gli
statuti che attualmente hanno, di svolgere un ruolo davvero
qualificante nell'offerta formativa universitaria. In sostanza:
●
se i corsi di laurea in lingue, grazie alle riforme cui accennavo,
saranno messi in grado di formare laureati realmente competenti nelle
lingue in quanto vive,
●
se, di conseguenza, i corsi di lingua nella Scuola saranno tenuti da
insegnanti realmente competenti nella loro materia,
●
se, dunque, confluiranno nelle facoltà universitarie matricole
che già sapranno leggere e conversare in lingua, come avviene
negli altri paesi europei,
●
allora i Centri Linguistici, qui a Perugia come altrove, potranno
dedicarsi a rispondere in modo qualificato ai bisogni specifici di
formazione degli studenti provenienti dalle diverse facoltà.
Questo
ruolo, non di infermeria ma di centro di specializzazione, lo
svolgono da tempo molti centri linguistici all'estero. Ecco due
esempi:
1.
Il Centro Linguistico di Lille, in Francia, riesce ad insegnare i
linguaggi settoriali – il linguaggio informatico o giuridico
dell'inglese o del tedesco, ad esempio – come routines
discorsivi. Ciò vuol dire che insegna agli studenti
non solo come interpretare ma anche come creare discorsi autentici
per poter parlare della loro disciplina in modo chiaro e
appropriato. I centri linguistici italiani, invece, sono spesso
costretti a limitarsi all'insegnamento fraseologico dei linguaggi
settoriali: gli studenti imparano locuzioni e termini tecnici in
lingua che poi utilizzeranno in incomprensibili periodi ricalcati su
modelli italiani, quando dovranno scrivere un saggio scientifico o
discutere una perizia. Ma non c'è altra scelta: durante
gli anni scolastici i giovani italiani non hanno acquisito le
necessarie pre-competenze testuali e conversazionali per poter
seguire un corso breve di perfezionamento.
2.
Il Centro Linguistico di Bristol, in Inghilterra, riesce ad insegnare
anche le macro-competenze settoriali: ad esempio, come fare una
presentazione in lingua ad un gruppo di lavoro, come fare ricerca in
lingua usando Internet, come gestire telefonate in lingua, come
affrontare in lingua un colloquio per una borsa di studio o per un
posto di lavoro, ecc. In Italia, invece, non si riesce ad
insegnare queste macro-competenze alla generalità degli
studenti. Infatti, è relativamente limitato il monte ore che
lo studente medio – proveniente da una facoltà non
linguistica – riesce a dedicare ai corsi presso un centro
linguistico, nell'arco della sua carriera universitaria. Quelle
ore, poi, sono assorbite quasi completamente in corsi per sistemare
le carenze di base e, sul piano psicologico, per far superare il
rifiuto inconscio verso le lingue straniere che lo studente ha
acquisito a scuola.
Se
una facoltà di medicina formasse male i medici ospedalieri,
chiaramente la risposta giusta non sarebbe quella di costruire
infermerie accanto agli ospedali per riabilitare i malati di questi
medici maldestri. La risposta giusta sarebbe quella di
riformare davvero il percorso di studio nelle facoltà di
medicina. Concludo, dunque, questa prima parte del mio
intervento augurando molto successo al nascente Centro Linguistico di
Perugia. E proprio perché ciò avvenga, augurando
anche che la comunità accademica nel suo insieme accetti di
esaminare complessivamente il problema dell'insegnamento delle lingue
all'università, di cui la necessità di costituire il
Centro Linguistico è solo la spia.
E'
chiaro che il problema non è perugino, ma nazionale.
Anzi, bisogna dare al corso di laurea in lingue di Perugia il credito
d'essere stato tra i primi ad indicare la strada giusta da seguire
per venirne fuori quando qualche anno fa, andando controcorrente, ha
creato uno dei primi insegnamenti di lingua inglese separato
dall'insegnamento della relativa letteratura. All'epoca fu
eresia: oggi è legge. Infatti, un recente decreto ha
stabilito che tutti i corsi di laurea in lingue in Italia debbano
avere cattedre specifiche per ogni idioma insegnato. Non
esisteranno più le cattedre di lingua e letteratura inglese o
francese che – non è un segreto per nessuno – nei
fatti erano cattedre di sola letteratura, essendo la componente
lingua affidata a figure "non docenti" – i lettori –
e pertanto inevitabilmente emarginata.
C'è
dunque un precedente che fa ben sperare a Perugia, nonché una
nuova legislazione nazionale su cui appoggiarsi. Ma i margini
di manovra rimangono comunque stretti: le scelte dei corsi di laurea
in lingue sono, ad esempio, necessariamente condizionate dalle
esigenze dell'intero settore umanistico. Ecco perché è
indispensabile che tutta la comunità accademica perugina si
unisca per aiutare il corso di laurea in lingue a realizzare bene le
riforme che il paese da tempo chiede. Se si riuscisse a
riformare autenticamente il corso di laurea in lingue, il
nuovo Centro Linguistico potrebbe realizzare appieno la sua vocazione
precipua: quella di insegnare ad usare con alta competenza –
nelle lingue straniere più richieste – il linguaggio dei
diversi settori disciplinari.
2.
Alle
considerazioni che precedono si potrebbero fare tre obiezioni.
La prima si riferisce alla già accennata suddivisione delle
cattedre di lingua e letteratura straniera in una cattedra di lingua
e una di letteratura. Con questa riforma, che procede
lentamente perché costosissima, si ipotizza che il problema
della competenza dei laureati in lingue dovrebbe essere risolto –
almeno in un prossimo futuro. La seconda obiezione riguarda la
riforma dei curricula, tuttora in corso: l'introduzione del sistema
dei moduli e l'eliminazione della titolarità degli
insegnamenti consente alle facoltà di lingue di rinnovare la
propria offerta didattica. Pare che già alcune facoltà
abbiano messo, nei propri programmi, insegnamenti che si avvicinano
al concetto di lingua viva. La terza obiezione ha a che
fare con la recente istituzione delle Scuole Superiori di
Insegnamento Secondario, le SSIS. Dal momento che queste scuole
sono obbligatorie per chi vuole insegnare nella Scuola, entro breve
tutti gli insegnanti avranno una specializzazione
pedagogico-disciplinare.
Con
queste riforme la soluzione è a portata di mano, dunque?
L'insieme di questi provvedimenti porrà fine all'attuale
carenza linguistica delle matricole? I Centri Linguistici, in
un prossimo futuro, potranno quindi offrire i servizi più
qualificati appena descritti?
Cominciamo
con la terza obiezione: da qualche anno vengono istituite in
tutta l'Italia le SSIS, ossia le Scuole Superiori di Insegnamento
Secondario. Garantiscono realmente un'adeguata preparazione a
chi insegnerà una lingua straniera nella Scuola?
Senza
un'autentica riforma dei corsi di laurea in lingua, la risposta sarà
negativa. Le SSIS, infatti, sono state concepite per fornire ai
laureati nelle varie discipline, tra cui lingue, soprattutto una
corretta impostazione pedagogica; cioè danno per scontato che
gli specializzandi abbiano già un'adeguata conoscenza della
loro materia – conoscenza forse da approfondire, ma comunque
già solida. Per quanto riguarda chi deve insegnare le
lingue, però, questa supposizione non regge – proprio
per via dell'emarginazione, nelle facoltà italiane,
dell'insegnamento delle lingue in quanto vive.
E'
vero che gli statuti delle SSIS prevedono anche approfondimenti nelle
materie disciplinari già studiate all'università ed è
su questo terreno che effettivamente la partita è ancora tutta
da giocare. Sarebbe possibile introdurre nei programmi delle
SSIS insegnamenti di lingua viva e delle discipline
concomitanti sotto l'etichetta delle linguistiche areali, a patto
che, nel contempo, venga dato maggiore spazio alle linguistiche
areali nei programmi. Il problema è dunque politico.
Chi deciderà quali approfondimenti dare e con quale peso?
Ad esempio, è ovvio che se una SSIS fa capo ad una facoltà
universitaria di lingue non ancora riformata, ci sarà il
rischio che il curriculum della SSIS riporti l'impronta disciplinare
tradizionale di questa facoltà. Ma chi può
pretendere di giudicare se una facoltà è o non è
"autenticamente" riformata? Non c'è un
organismo ufficiale di controllo della fondatezza delle scelte
dottrinali, come per la magistratura. Ecco perché, in
definitiva, le SSIS rappresentano non tanto una risposta quanto la
promessa di una risposta che, per realizzarsi, richiede
l'interessamento di tutta la comunità accademica. E'
l'idea base di questo intervento, infatti, che il successo di un
Centro Linguistico richieda l'interessamento dell'intera comunità
accademica alla questione "lingua" nel suo complesso –
comprendendo, quindi, anche le scuole di specializzazione.
Aggiungo
un'ultima osservazione. Anche se le SSIS fossero impostate come
si è appena detto, non basterebbe. Occorrerebbe pur
sempre che nel contempo i corsi di laurea fossero riformati
autenticamente. Secondo la mia esperienza e quella di
moltissimi colleghi, infatti, non è facile far acquisire la
nozione di "interiorizzazione culturale" agli
specializzandi della SSIS, perché anche loro sono stati
abituati per anni alla tradizionale analisi formale delle lingue come
sistemi. Le difficoltà aumentano se gli specializzandi
hanno studiato quasi esclusivamente, come campioni di linguaggio,
testi scritti non spontanei – il caso di tutti i laureati
dell'indirizzo letterario. Studenti formati secondo questa
tradizione acquisiscono una forma mentis da filologo delle
lingue morte, di grande valore culturale indubbiamente, ma non una
forma mentis da etnografo, cioè quella che serve per
saper interiorizzare le lingue vive. Ed è arduo, in
seguito, cambiare quest'abitudine mentale. Naturalmente, la
forma mentis filologica e la forma mentis etnografica
possono coesistere benissimo nella stessa persona: basta scorrere le
pagine di un illustre filologo come Antonino Pagliaro per accorgersi
che il testo antico può essere visto contemporaneamente come
indizio e come espressione d'una cultura non statica ma in movimento,
aperta all'indagine sperimentale (Pagliaro, 1969). Ma il tipico
laureato in lingue non ha acquisito una visione di questa
ampiezza dello studio filologico (o linguistico-descrittivo).
E' ovvio, dunque, che non può bastare un singolo modulo di
linguistica areale – condotto alla SSIS come lingua viva
– perché quel tipico laureato cambi ottica. Che,
ad un tratto, egli cominci a vedere le regole grammaticali di una
lingua straniera non come leggi fisse ma come ipotesi da appurare
etnograficamente. Che egli cominci a vedere una conversazione
in lingua non come battute di un copione bensì come la
co-costruzione di una Weltanschauung condivisa – un
happening teatrale semmai. E via di questo passo.
Queste
considerazioni spiegano perché il successo del nuovo Centro
Linguistico dell'Università di Perugia dipenda anche dalla
qualità della formazione data dalla SSIS e dal corso di laurea
in lingue: il sistema è un tutt'uno.
Passiamo
ora alla seconda obiezione. E' in atto, si dice, una
riforma curricolare dei corsi di laurea in lingue provocata
dall'eliminazione della titolarità degli insegnamenti e
dall'introduzione dei moduli. Ma questa riforma consentirà
davvero alle facoltà e ai corsi di laurea in lingue di
rinnovare e diversificare la loro offerta?
Forse
no. Posso citare – a sostegno di questo pessimismo –
un precedente storico. Anche la riforma dei curricula di lingue
realizzata all'inizio degli anni '80 doveva diversificare l'offerta
didattica. All'epoca dominava il curriculum
filologico-letterario; la riforma aggiunse un nuovo curriculum
denominato storico-culturale, per formare all'interpretazione
di testi non-letterari. Aggiunse anche un curriculum
linguistico-glottodidattico per formare allo studio formale delle
lingue e al loro insegnamento. Infine, aggiunse un curriculum
linguistico-antropologico per formare allo studio
dell'interazione orale in lingua. Qual è stato il
risultato di questa riforma dopo vent'anni? Dal 1980 al 2000
l'offerta didattica dei Corsi di Laurea in Lingue è rimasta
sostanzialmente invariata – sempre d'impronta
filologico-letteraria – esattamente come prima della riforma.
Di fatto, in questi anni non sono nate nuove cattedre per i curricula
storico-culturale o antropologico e, nella maggior
parte delle università, si sono create poche cattedre per il
curriculum linguistico-glottodidattico. Ma nello stesso
periodo il numero delle cattedre filologico-letterarie è
raddoppiato. Senza cattedre diversificate, non è stato
possibile offrire agli studenti curricula realmente diversificati.
I nuovi curriculum c'erano, ma in larga misura soltanto sulla carta.
Ecco
perché l'attuale riforma dei corsi di laurea in lingue
dev'essere seguita attentamente. L'abolizione della titolarità
dell'insegnamento promette molto, ma l'esperienza dimostra che
bisogna vigilare perché tale promessa venga mantenuta. A
chi spetta il compito di vigilanza? La risposta è
semplice: nell'era della globalizzazione spetta a tutta la comunità
accademica, perché a tutti interessa che l'Italia abbia un
sistema di formazione in lingue pari alle nuove esigenze.
Infine,
contando alla rovescia, arriviamo alla prima obiezione: essa
riguarda la separazione in due delle cattedre di lingua e di
letteratura straniera. Basterà dunque la creazione di
autonome cattedre per consentire, finalmente, lo svolgimento degli
insegnamenti di lingua da parte di professori ufficiali, anziché
da parte di figure che non hanno lo status accademico di docente
(lettori, esercitatori, esperti), come è avvenuto fino ad
oggi?
Non
necessariamente. Il rischio dello svuotamento di questa
riforma, per chi conosce il meccanismo di reclutamento concorsuale
all'università, è fin troppo ovvio: le nuove cattedre
di Lingua Straniera potrebbero essere assegnate – in base alla
normativa vigente – a studiosi formatisi principalmente come
letterati o come linguisti descrittivi, studiosi di indubbio valore
accademico ma non nel campo specifico dello studio e
dell'interiorizzazione delle lingue in quanto vive. Del
resto, ciò è già avvenuto. Se la tendenza
dovesse generalizzarsi, lo Stato spenderebbe l'equivalente di
migliaia di miliardi di lire per creare centinaia di nuove cattedre
di Lingua, il tutto per duplicare l'attuale offerta didattica
– proprio l'offerta che si voleva riformare.
Si
sente parlare, in alcuni Facoltà di lingue, di un escamotage
per poter garantire agli studenti vere e proprie lezioni di lingua
viva, pur nominando alle nuove cattedre di lingue "letterati"
e "linguisti descrittivi". La soluzione consisterebbe
nell'obbligare gli studenti a seguire al Centro Linguistico corsi di
"lingua parlata" tenuti dai lettori.
Considero
questa soluzione, appunto, un escamotage e inoltre un escamotage
estremamente nocivo, sia per gli studenti di lingue – i futuri
insegnanti nella scuola – sia, di conseguenza, per le future
leve di matricole di tutte le facoltà. Perché due
sono le ipotesi:
● o i corsi tenuti dai lettori nei
Centri Linguistici saranno solo esercitazioni spicciole e quindi non
costituiranno vere e proprie lezioni di lingua viva (quindi
non prepareranno gli studenti di lingue a fare i futuri insegnanti,
traduttori, mediatori, negoziatori, ecc.);
● o questi corsi saranno insegnamenti
veri e propri di lingua viva ma in tal caso daranno
inevitabilmente luogo ai problemi giudiziari che l'università
affronta da anni, anche in sede internazionale. (Lo spostamento dei
lettori in un Centro Linguistico non cambierà la sostanza
della questione.) Mi riferisco alle vertenze promosse dai
lettori, non contro il mancato riconoscimento della loro funzione
docente (i tribunali non possono ordinare assunzioni ope legis ed è
giusto che sia così), ma contro il mancato pagamento del
corrispettivo associato alla loro funzione docente. Si tratta
di vertenze da evitare assolutamente perché, anche quando le
vincono, i lettori continuano ad essere emarginati nelle facoltà
(non possono parlare d'ufficio o votare nei consigli, non possono
attingere a fondi di ricerca, ecc.) con una ricaduta sulla didattica
inevitabilmente negativa. In altre parole, le università
finiscono col dover pagare un docente intero per avere un docente
dimezzato.
Ma
più in generale, la proposta di dividere i compiti in due –
ai professori l'insegnamento descrittivo delle lingue, ai
lettori l'insegnamento vivo delle lingue – è un
controsenso didattico ed accademico. Per rendersene conto,
basta immaginare l'assurdità di una facoltà di
architettura con posti di professore per chi insegna storia
dell'architettura o teoria dei sistemi e posti di esercitatore per
chi insegna disegno, urbanistica, calcolo e statica, insomma le
cosiddette materie tecniche. Oppure un corso di laurea in
archeologia con posti di professore per chi insegna la storia degli
scavi e posti di esercitatore per chi insegna agli studenti come
scavare. Sarebbe assurdo in quanto, per cominciare con l'ultimo
esempio, è proprio nel come scavi che getti le basi per
le conclusioni a cui potrai pervenire; pertanto sono i professori
ordinari ed associati di archeologia a portare gli studenti sul campo
e a dirigere i loro lavori. Nel caso dell'architettura, è
proprio nel saper creare un tracciato che corrisponda ai bisogni di
spazio e di movimento di una determinata utenza che sta la funzione
dell'architetto; perciò sono i professori ordinari ed
associati ad insegnare disegno e statica. Stesso discorso per
quanto riguarda l'apprendimento delle lingue straniere: è come
scavi nelle parole del tuo interlocutore straniero che determina se
capirai o meno dove lui vuole realmente parare; è come
costruisci e dici frasi in lingua che determina se riuscirai o meno a
produrre su di lui gli effetti che desideri. Non è
concepibile, dunque, lasciare questi delicati insegnamenti ad
esercitatori, isolati poi in un centro senza legami organici con gli
altri insegnamenti (antropologici, etnografici, psicolinguistici,
filosofici) che completano una corretta formazione nelle lingue in
quanto vive.
A
rifletterci bene, l'utilizzazione dei Centri Linguistici per
consumare – attraverso la separazione fisica – la
frattura tra chi fa "corsi" e chi fa "esercitazioni"
nel settore lingue, non fa altro che accentuare l'insoddisfacente
situazione che vigeva prima della separazione delle cattedre di
lingua e letteratura straniera. Con il nuovo sistema, i
laureati in lingue avranno un bagaglio in linguistica descrittiva al
posto del bagaglio in filologia che avevano con il vecchio sistema;
ma continueranno a non sapere le lingue come forma mentis.
I lettori avranno a disposizione modernissimi mezzi tecnologici al
posto della sola lavagna (e non sempre del gesso) di prima; ma
continueranno ad avere la motivazione ad innovare di chi debba
lavorare senza reali prospettive di carriera. Per
riprendere la celebre formula di Tancredi ne Il Gattopardo, si
sarà cambiato tutto affinché tutto rimanga com'era.
A chi destinare, allora, le nuove cattedre di Lingua, se non a
"linguisti descrittivi" o a "letterati con qualche
interesse linguistico"? Per rispondere basta osservare il
comportamento delle università all'estero che insegnano
l'italiano come lingua straniera. Nella quasi totalità
dei casi (qualche eccezione naturalmente esiste) non ci sono
preferenze per docenti italiani ma non ci sono nemmeno intese per
escluderli a priori: le cattedre di lingua possono essere assegnate a
chiunque abbia la capacità di traghettare gli studenti nei
gironi sempre più stretti che portano al cuore dell'attività
espressiva.[Cliccare qui> 4]
Nei fatti, le cattedre sono assegnate indifferentemente sia a
cittadini italiani sia a cittadini del posto, con il solo
denominatore comune che tutti hanno comprovate capacità
nell'insegnare l'espressione in lingua (che sottintende la
descrizione della lingua ma che va ben oltre) di discorsi
spontanei, co-creati e culturalmente mirati.
Dove
si possono trovare giovani docenti con queste capacità in
Italia da reclutare per i nuovi posti? In verità, ci
sono tantissimi giovani talenti che insegnano nelle scuole, talenti
che rischiano di essere esclusi dall'insegnamento universitario se le
facoltà selezionano, per il dottorato o per i posti di
ricercatore, solo chi abbia titoli linguistici tradizionali o titoli
letterari. Ci sono ottimi docenti italiani nei centri culturali
italiani all'estero, i quali hanno portato avanti, accanto al loro
lavoro d'insegnamento dell'italiano come lingua viva,
approfondite ricerche sulla lingua del posto. Ci sono
ricercatori nelle scienze della comunicazione, nelle scienze
antropologiche e al DAMS che, opportunamente incentivati, potrebbero
fare il passaggio. Ci sono anche, nelle stesse facoltà
di lingue, linguisti e letterati con lunghi percorsi di ricerca e di
didattica incentrati sulla lingua viva in quanto espressione
spontanea. Inoltre, ci sono diversi lettori di madrelingua
straniera con i titoli necessari, reclutati per svolgere
esercitazioni subalterne ma che poi, in mancanza di insegnamenti
ufficiali di lingua viva, hanno trasformato quelle
esercitazioni in insegnamenti più qualificati.
Certo,
in un primo tempo bisognerà avere il coraggio di lasciare
vuoti quei concorsi in cui non si presenteranno candidati con i
titoli necessari. Mi rendo conto che, come conseguenza, si
ritarderà l'attuazione della riforma; inoltre, perdureranno i
problemi affrontati quest'anno nel gestire gli esami dei settori
L-LIN senza il personale adeguato. Ma ritardare la riforma è
meglio che seppellirla procedendo a nominare chi non ha titoli che
attestano un impegno qualificato pluriennale nella ricerca e nella
didattica delle lingue in quanto vive.
In conclusione, per garantire
che i corsi di laurea in lingua compiano una riforma sostanziale e
non puramente formale, è necessario vigilare su tre fronti:
l'assegnazione delle nuove cattedre di Lingua, la creazione dei nuovi
moduli e curricula, la definizione delle materie disciplinari da
insegnare nelle Scuole Superiori d'Istruzione Secondaria.
A far bene i conti, le facoltà
scientifiche e umanistiche avrebbero interesse ad investire tempo ed
energia per seguire l'andamento di queste tre riforme nel settore
lingue. Infatti, se le riforme venissero realizzate
correttamente e se il Centro Linguistico potesse dunque essere non
una infermeria bensì un centro di specializzazione, queste
facoltà avrebbero un problema in meno da risolvere. Il
problema è quello posto attualmente dalla necessità di
concedere crediti sufficienti per la formazione linguistica dei loro
studenti, senza nulla togliere alla loro formazione disciplinare.
Al momento attuale, visto il livello medio delle conoscenze
linguistiche delle matricole, l'ipotesi di assegnare dai 4 ai 10
crediti per i corsi del Centro Linguistico è del tutto
irrealistica – ci vorrebbero dai 16 ai 24 crediti a seconda
della facoltà (ad esempio, 16 per scienze naturali, 24 per
scienze politiche). Ma quei 4 o 10 crediti potrebbero essere
sufficienti se i Centri Linguistici, grazie alle riforme dei corsi di
laurea in lingue, potessero limitarsi ad offrire brevi corsi
specialistici mirati a matricole già linguisticamente
preparate.
Concludo
questa parte dell'intervento ricordando come il titolo di questo
convegno – la ridefinizione del ruolo linguistico del CLA nella
prospettiva dei nuovi ordinamenti didattici – sottolinea
egregiamente il rapporto che esiste tra le varie riforme in atto
viste complessivamente. Questo titolo costituisce di per
sé un invito alla comunità universitaria tutta intera a
seguire da vicino l'attuazione dei nuovi provvedimenti nel settore
lingue.
3.
A
questo punto abbiamo gettato tutte le premesse necessarie per poter
rispondere alla questione posta dal titolo di questo intervento:
Quale
ruolo deve svolgere il Centro Linguistico rispetto alle diverse
categorie di utenza, in particolare rispetto agli studenti delle
facoltà scientifiche e a quelli delle facoltà
umanistiche?
A
mio parere bisogna innanzitutto distinguere tre categorie di
possibili utenti, non solamente due. Bisogna poi precisare
meglio in che cosa consistono i termini "studenti delle facoltà
scientifiche" e "studenti delle facoltà
umanistiche".
Cominciamo
con il primo punto, il più spinoso. Nell'enunciarlo, mi
rendo conto di esprimere un parere in contrasto sia con il progetto
organizzativo del nascente Centro Linguistico di Perugia, sia con la
prassi consolidata di molti centri linguistici in Italia.
Dicevo,
dunque, che ritegno necessario distinguere tre categorie di possibili
utenti. Due sono le categorie di studenti da accogliere
senz'alcun dubbio nei Centri Linguistici, vale a dire gli studenti
delle facoltà scientifiche e quelli delle facoltà
umanistiche. La terza categoria è costituita dagli
studenti del corso di laurea in lingue ed è una categoria che,
a mio parere, va esclusa dalla frequentazione del Centro.
Nella
prima parte di questo intervento abbiamo visto, infatti, che i
bisogni linguistici di uno studente di lingue sono radicalmente
diversi da quelli degli altri studenti dell'area umanistica e degli
studenti dell'area scientifica. Agli studenti di lingue serve
una formazione comunicativo-culturale – basata sulla
trasformazione del sé descritta prima – che va
ben al di là di ciò che possa offrire un semplice
centro di servizi, il cui ambito di ricerca sarà
necessariamente limitato per via dell'impossibilità statutaria
di avere professori e ricercatori stabilmente inquadrati. La
formazione degli studenti di lingue, dunque, va condotta
necessariamente all'interno di un corso di laurea, sia per poter
attingere a fondi di ricerca come qualsiasi altro settore accademico,
sia per trovare agganci con i docenti delle materie complementari
(antropologia culturale, etnografia, ermeneutica, ecc.), i quali
difficilmente confluirebbero in un consorzio di ricerca facente capo
ad un Centro Linguistico.
Al
contrario, per risolvere i bisogni linguistici degli studenti delle
aree scientifiche e umanistiche, il Centro Linguistico rappresenta
senz'altro la soluzione più razionale a patto che vengano
riformate autenticamente i corsi di laurea in lingue. I
bisogni di queste due categorie di utenza, infatti, sono di tipo
comunicativo e non comunicativo-culturale –
bisogni che possono essere facilmente soddisfatti in un Centro di
servizi tramite corsi specialistici di breve durata e di pochi
crediti, messi a punto da chi insegna nel Centro in collaborazione
con ricercatori e docenti "prestati" di volta in volta da
un consorzio di dipartimenti (scienze linguistiche, scienze
pedagogiche, psicologia, ecc.) interessati allo studio empirico di
alcuni fenomeni linguistici e psicolinguistici circoscritti quali
l'uso dei linguaggi settoriali ed dei generi espositivi,
l'apprendimento della lettura in lingua, l'interlingua e le
interferenze L1/L2 e via discorrendo.
In
sostanza, gli studenti di scienze e gli studenti di storia che hanno
bisogno di sapere – per dare un esempio – l'inglese o il
tedesco per fare ricerche bibliografiche, possono seguire corsi in
cui gli apparati bibliografici in queste due lingue vengono insegnati
come sistemi puramente formali. Si tratta di una visione
superficiale di ciò che è una lingua ma del tutto
funzionale, dati i limitati bisogni dell'utenza. Ecco perché
condivido i discorsi fatti da Maurizio Gotti oggi e da Paola
Evangelisti ieri, se parliamo di queste due categorie di utenza e non
degli studenti di lingue.
Naturalmente
una lingua non è solo un insieme di forme fonologiche e
lessico-grammaticali abbinate ad un insieme di usanze pragmatiche.
Una lingua è molto di più, come abbiamo ricordato nella
prima e nella seconda parte di questo intervento. Tuttavia,
allo studente di scienze o allo studente di storia, scoprire quel "di
più" generalmente non serve e raramente interessa.
Per
lo studente di lingue, invece, è proprio il contrario: si è
iscritto al corso di laurea in lingue proprio per scoprire quel "di
più". Non solo, ma ha bisogno di saperlo
cogliere, in quanto è proprio questa capacità che
giustificherà il suo futuro ruolo come mediatore tra lingue e
culture. Anzi, può risultare dannoso e demotivante per
questo studente trattare le lingue puramente come codici da
analizzare (ne ho già parlato a proposito degli specializzandi
delle SSIS).
Si
potrebbe obiettare che ci sono, però, anche a Lingue matricole
che hanno un basso livello di preparazione linguistica iniziale.
Non sarebbe il caso di concedere almeno a questi studenti di lingua
la possibilità di frequentare il Centro Linguistico per
colmare il proprio debito formativo?
Rispondo
di no per il motivo già ribadito più volte in
quest'intervento: un programma che insegna una lingua come se fosse
soltanto un sistema formale da usare per decodificare messaggi --
l'impostazione inevitabilmente adottata nei Centri Linguistici per
venir incontro ai bisogni degli studenti di scienze -- è un
programma nocivo a qualsiasi livello per chi intende laurearsi
in lingue. Per questa utenza occorrono insegnamenti ad hoc
tenuti presso un corso di laurea.
Sarò
eccessivo, forse, ma ritengo che l'accesso al Centro Linguistico
dovrebbe essere addirittura vietato per statuto agli studenti di
lingue. Un divieto del genere, infatti, sarebbe a tutto
vantaggio della qualità dell'insegnamento impartito ai futuri
laureati in lingue. Tre sono i motivi:
1.
anche se fossero avviati insegnamenti ad hoc per gli studenti di
lingue presso un Centro Linguistico, essi tenderebbero col tempo ad
appiattirsi sui corsi più seguiti, ossia sui corsi puramente
"meccanici" per le facoltà scientifiche. I
motivi sono di natura squisitamente umana: la demotivazione di chi
deve portare avanti un'innovazione didattica così impegnativa
in una situazione di obiettivo isolamento e di assenza totale di
sbocchi di carriera; la tendenza di voler "contenere le spese"
riciclando materiali usati nei corsi più seguiti (quelli
"meccanici"), ecc.;
2.
se l'accesso al Centro fosse vietato agli studenti di lingue, il
Corso di Laurea in Lingue sarebbe incentivato a ricercare una
formazione disciplinarmente più mirata per i suoi studenti sin
dai primi livelli, ossia sin dalla fase più critica per
l'acquisizione di ciò che abbiamo chiamato la forma mentis
da etnografo;
3.
infine, trasferire al Centro Linguistico i corsi per gli studenti di
lingue, manderebbe un brutto messaggio a questi studenti, molti dei
quali saranno futuri insegnanti nella Scuola. Il messaggio
sarebbe: "Gli insegnamenti della linguistica descrittiva e della
letteratura straniera sono cose serie perché tenute da
professori ufficiali all'interno di una facoltà universitaria;
mentre l'insegnamento delle lingue in quanto vive è
roba da centro di servizio, da affidare a chi non riveste nemmeno la
qualifica di professore".
Esaminiamo
ora i termini "studenti delle facoltà scientifiche"
e "studenti delle facoltà umanistiche": sono termini
di comodo che andrebbero meglio precisati, se vogliamo definire la
tipologia degli insegnamenti che il Centro Linguistico, nella sua
veste attuale, può offrire.
Quando
parliamo dello "studente di scienze" indichiamo qualsiasi
studente – delle facoltà scientifiche e non – che
abbia bisogno di sapere le lingue come codici per la trasmissione di
informazioni convenzionali – o, meglio, di informazioni che
sembrano in prima istanza puramente convenzionali, cioè senza
implicazioni pragmatiche o culturali oltre a quelle che queste
informazioni hanno quando vengono espresse in qualsiasi
lingua.
Perciò
il termine "studente di scienze" ingloba non solo lo
studente di medicina, di fisica o di informatica, ma anche lo
studente di economia o di archeologia o di storia dell'arte che abbia
necessità di sapere una determinata lingua per leggere
articoli puramente scientifici. In linea di massima, questo
tipo di utente non deve saper usare la lingua per interagire
spontaneamente ed autenticamente in situazioni culturalmente dense.
Per quanto riguarda il parlato, egli ha tutt'al più bisogno di
saper tirare fuori dal suo repertorio di routines in lingua
quanto basta per ordinare un pasto, riservare una stanza d'albergo,
fare i convenevoli con gli altri partecipanti di un congresso, ecc.
Non deve integrarsi nella cultura di un altro paese e nemmeno
risultare particolarmente convincente quando ordina un pasto o saluta
i suoi colleghi stranieri. Questo tipo di utente, lo "studente
di scienze", potrà un domani avvalersi di un traduttore o
di un interprete quando, in una lettera o in un'intervista, egli
vorrà esprimere discorsi ricchi di sfumature.
Indubbiamente,
non esistono discorsi perfettamente convenzionali, né in uno
scritto scientifico, né in convenevoli del tipo "Hello"
o "Hi" scambiati con un interlocutore anglofono.
Paola Evangelisti e Carla Vergaro hanno dimostrato che anche un testo
scientifico o una lettera commerciale contengono valenze pragmatiche
ed esistenziali culturalmente marcate. Non cogliere queste
valenze è effettivamente una perdita di informazioni.
Tuttavia, dal momento che gli studenti di scienze non hanno né
il tempo né la voglia d'imparare appieno le lingue sul piano
culturale, possono limitare il proprio apprendimento alla
comprensione dei soli contenuti pragmaticamente e culturalmente
affini alle loro personali abitudini discorsive in italiano, in
quanto specialisti in un particolare dominio scientifico.
La
sede naturale per colmare i bisogni linguistici dello studente di
scienze è dunque il Centro Linguistico. Infatti, si
tratta di bisogni che necessitano di corsi brevi ed intensivi,
incentrati su competenze ricettive più che produttive, come la
lettura rapida (skimming, scanning) o la tecnica per prendere appunti
durante le conferenze. Questa categoria di studenti, peraltro,
non ha bisogno di grandi capacità conversazionali in lingua;
ciò che avrà già imparato a scuola (sempre
nell'ipotesi che i corsi di laurea in lingue vengano riformati)
dovrebbe bastare.
La
seconda categoria di utenza è costituita dagli studenti
provenienti dalle facoltà umanistiche. Uso questo
termine, come quello precedente, per pura comodità.
Infatti, abbiamo appena visto che uno studente umanista –
poniamo di storia dell'arte – potrebbe benissimo voler limitare
la sua padronanza dell'inglese o del tedesco a quegli usi
rappresentativi convenzionali che sono tipici degli studenti di
scienza: saper leggere schede bibliografiche in lingua, saper
prendere appunti "tecnici" in lingua, e via discorrendo.
Questo tipo di studente umanista è però un'eccezione.
Normalmente
ciò che caratterizza gli studenti delle facoltà
umanistiche – a cui possiamo aggiungere anche le facoltà
economico-politiche e giuridiche – è la necessità
di sapere le lingue per agire sulle persone. Saper agire
significa, ad esempio, riuscire a fare una presentazione convincente
in inglese per un gruppo di lavoro internazionale, oppure risultare
affabile in francese per ottenere, al telefono, un'informazione
desiderata. Si tratta di macro-competenze basate sulla gestione
di discourse routines pragmaticamente connotati.
In una parola, lo studente umanista deve saper usare la lingua
straniera non solo per rappresentare le sue idee, come lo studente di
scienza, ma anche per sollecitare determinati comportamenti, tramite
strategie pragmaticamente appropriate e, nei casi più
ricorrenti, culturalmente universali.
I
corsi rivolti a questa seconda categoria d'utenza saranno perciò
più lunghi e più "pesanti" in termini di
crediti – da 8 a 10 di regola. Ma per lo studente di
giurisprudenza o di scienze della comunicazione, imparare a fare una
presentazione convincente in inglese o a presentarsi in modo amabile
in francese fa parte della propria formazione disciplinare
quale futuro avvocato o quale futuro addetto stampa. Cioè
nell'imparare a comunicare con destrezza in inglese, lo studente
impara sia l'inglese sia cosa significa comunicare con destrezza in
un contesto interculturale. Dunque si può giustificare
senz'altro il maggiore "peso" in termini di crediti, in
quanto corsi di questo tipo vanno visti come parte integrante
dell'iter formativo specifico di un corso di laurea "umanistica".
Il
Centro, quindi, dovrebbe disporre di materiali diversificati in
almeno due filoni, quelli appena indicati con le etichette
"scientifico" e "umanistico" ma che andrebbero
meglio designati con le etichette "discorsi tecnici"
e "discorsi intenzionali".
Ad
esempio, per insegnare la lettura rapida in inglese il Centro
dovrebbe poter offrire:
materiali
studiati per i bisogni limitatissimi della prima categoria di
utente: studenti che devono capire discorsi tecnici (articoli
espositivi, specifiche, schede bibliografiche...), non importa se
frequentano una facoltà scientifica o una facoltà
umanistica;
e
materiali diversi per la seconda categoria di utente: studenti che
devono capire discorsi intenzionali (lettere commerciali,
contratti, discorsi politici..., cioè testi che giocano anche
sulla natura degli atti linguistici compiuti), non importa se questi
studenti frequentano una facoltà scientifica o una facoltà
umanistica;.
Questo
modo di procedere prescinde dunque dal contenuto tematico dei testi
orali o scritti. Infatti, il Centro si prefigge di insegnare
competenze in lingua (come leggere velocemente, prendere
appunti, fare presentazioni), non vocaboli specialistici che
gli studenti non hanno difficoltà ad imparare per conto
proprio. Perciò possono confluire nello stesso corso –
poniamo un corso su "come fare presentazioni in inglese
(discorsi tecnici)" – sia studenti di biologia che
studenti di archeologia; il contenuto tematico dei lucidi usati per
le presentazioni è d'importanza secondaria. Per lo
stesso motivo, possono seguire il medesimo corso su "come
prendere appunti in spagnolo (discorsi intenzionali)" sia
studenti di scienze della comunicazione che studenti di scienze
dell'ambiente, i quali vogliono poter seguire (in TV satellitare) i
dibatti in Spagna sulla relativa legislazione del settore.
La
ripartizione binaria dei materiali e dei corsi ha il vantaggio di
limitare la duplicazione di stampati e la proliferazione di corsi.
Inoltre, l'insegnamento stesso risulta meglio focalizzato sulle
funzioni comunicative. Infine consente allo studente di
personalizzare il suo percorso formativo. Poniamo, ad esempio,
che la facoltà dello studente X gli concede 8 crediti da
spendere al Centro per lezioni d'inglese. Questo studente, in
base alle proprie inclinazioni ed aspirazioni future, può
distribuire gli 8 crediti tra i vari moduli di lingua inglese offerti
dal Centro (come prendere appunti, come scrivere un articolo
scientifico, come fare una presentazione, come interpretare il
linguaggio non verbale dell'interlocutore...) scegliendo liberamente
tra l'opzione "discorsi tecnici" o "discorsi
intenzionali". I moduli basati sui discorsi tecnici
generalmente richiedono meno tempo, meno crediti e meno impegno.
Sarebbe
opportuno avviare nei Centri anche appositi corsi in lingua italiana
per tutti quegli studenti che non conoscono le caratteristiche dei
genres espressivi che dovranno poi padroneggiare in lingua.
Ciò consentirebbe successivamente al docente di lingue di
andare più spedito nelle sue lezioni e di limitare il ricorso
all'italiano per le spiegazioni metalinguistiche. Ad esempio,
prima di ammettere uno studente ad un corso di lettura (o di
redazione) di articoli scientifici, il Centro accerterebbe le sue
conoscenze pregresse di questo genre in italiano.
L'insufficienza comporterebbe la frequentazione obbligatoria di
alcune lezioni in italiano sul genre "articolo
scientifico", con esercitazioni pratiche (ma senza crediti, in
quanto recupero di un debito formativo).
Per
quegli studenti delle due categorie che vogliono assimilare una
lingua nella sua complessità reale – come fanno gli
studenti di lingue – dovrebbe essere prevista la possibilità
di frequentare un ampio ventaglio di moduli presso, appunto, il corso
di laurea in lingue. Molte università all'estero
prevedono dual degrees, ossia lauree composte per la metà
di una disciplina e per la metà di un'altra. Questa
possibilità consente di venir incontro, per esempio, allo
studente che s'interessa all'ingegneria informatica ma che non
desidera concentrare i propri studi in quella disciplina, preferendo
studiare contemporaneamente anche le tecniche della comunicazione, in
vista di un futuro lavoro nel campo del marketing o delle public
relations nel settore informatico. Gli statuti di molte
università americane consentono a questo studente, per
l'appunto, di fare una laurea per metà in ingegneria
informatica e per l'altra metà in scienze della
comunicazione. Una simile innovazione potrebbe portare, dunque,
studenti di scienze o studenti di economia nelle aule del corso di
laurea in lingue.
4.
Vediamo
ora qual è la giustificazione teorica della suddivisione degli
utenti, appena illustrata, in tre categorie funzionali.
La
giustificazione sta nella concettualizzazione dell'atto comunicativo,
che ho già sviluppato in altra sede (Boylan 2002) e che vorrei
riproporre qui. Ritengo, infatti, che l'atto comunicativo –
dall'ammiccamento all'allocuzione solenne – abbia una funzione
tripartita. Comunichiamo cioè per: 1. rappresentare
qualcosa, 2. fare qualcosa e 3. essere qualcosa.
Tradizionalmente
solo la prima funzione – la rappresentazione – viene
trattata dagli studiosi del linguaggio. Essi hanno elaborato,
attraverso i secoli, complessi schemi di analisi (la grammatica, la
lessicologia, la fonologia...) per descrivere come rappresentiamo
"plasticamente", tramite significanti, i nostri significati
(le cui proprietà generali vengono descritte poi con altri
schemi di analisi: la semantica, la semiotica...).
Da
circa un secolo, però, la linguistica si è accorta che
la comunicazione serve non solo per rappresentare le cose ma anche
per far accadere le cose: accanto alla linguistica è nata la
disciplina sorella denominata la
pragmatica.
Paragoniamo queste due discipline, per vedere in che cosa consiste la
differenza di prospettiva. Se grido: "Aaaooo, la porta!»,
un parlante italiano capirà immediatamente che gli sto
chiedendo di chiudere una porta che egli ha lasciato aperta –
ma non per qualche regola grammaticale. Non ho usato
l'imperativo. Il mio grido, perciò, non rappresenta
formalmente un ordine. O meglio, se rappresenta un ordine, è
in virtù di un altro sistema di regole a cui implicitamente
faccio riferimento. Si tratta delle presupposizioni
conversazionali nonché delle regole sociali che definiscono
ordini indiretti e modalità di convivenza. Secondo il
primo sistema di regole, se un parlante attira l'attenzione con un
tono esclamativo su un determinato oggetto, come una porta, egli
vuole far capire che c'è qualcosa da segnalare riguardo
all'oggetto. In base al secondo sistema di regole, dal momento che è
meritorio rendere un servizio laddove c'è bisogno e, inoltre,
dal momento che le porte d'entrata vanno tenute chiuse nella nostra
società, allora il richiamare l'attenzione su una porta
d'entrata lasciata aperta equivale a chiedere che venga chiusa, senza
che ci sia bisogno di usare un verbo all'imperativo. Cioè,
quando grido "Aaaooo, la porta!" non sto costruendo una
frase ellittica in cui sottintendo il verbo "chiudere"
all'imperativo, ma sto esprimendo due enunciati orali che hanno il
valore di due ordini indiretti per via di determinate regole sociali
(pragmatiche), non grammaticali.[Cliccare
qui> 5]
Esistono
dunque regole grammaticali, ma esistono anche regole pragmatiche: per
sapere una lingua bisogna conoscere entrambi i sistemi. (Sto
usando i termini "regole" e "sistemi" solo per
convenzione.) In quest'ultimo secolo abbiamo imparato, dunque,
che una lingua non è soltanto un mezzo per rappresentare idee
ma è anche un mezzo per agire sulle persone e sugli eventi (o
per far agire le persone e per far compiere determinati eventi).
Evangelisti ha illustrato ieri questo doppio gioco.
Ma
un'espressione verbale non è soltanto un mezzo per
rappresentare qualcosa e per far fare qualcosa. E' anche –
soprattutto – un mezzo per essere qualcosa.
Infatti, attraverso l'espressione, verbale e non verbale, noi ci
esplicitiamo e perciò siamo. Nell'interazione con gli altri ci
definiamo esistenzialmente.
Chiaramente
non ci definiamo ab ovo: ci definiamo usando i materiali
forniti dalla nostra comunità e quindi, nel definirci come
individui, ci definiamo anche come membri di una determinata
cultura (o, meglio, di un intreccio di culture). Possiamo
dipingerci secondo il nostro ingegno, ma la tavolozza che usiamo
viene fornita dalla nostra società ed essa condiziona (colora)
qualsiasi risultato raggiungiamo.
Bisogna
riconoscere che le persone che hanno meglio colto questo terzo
aspetto della produzione verbale – il linguaggio come modalità
d'essere – non sono stati i linguisti bensì i
letterati. Il critico letterario, attraverso lo studio del
linguaggio di un autore e dei suoi personaggi ha da sempre cercato di
definire la loro modalità d'essere. Potremmo addirittura
dire che lo scopo di un insegnamento comunicativo-culturale di una
lingua viva è quello, appunto, di dare questo taglio
"letterario" allo studio e all'assimilazione delle modalità
d'interazione quotidiane in una determinata lingua e cultura
straniera.
Diamo un esempio concreto per illustrare le tre diverse prospettive,
cioè l'uso del linguaggio per 1. rappresentare, 2. agire, 3.
essere. In una discussione con un giapponese, la gestione dei
silenzi fa parte di una adeguata competenza comunicativa: non sai
parlare il giapponese – o parlare in italiano o in inglese con
un giapponese – se non sai anche tacere per cogliere il
pensiero altrui (o per contemplare il tuo) e per sentire l'evolversi
dei rapporti interpersonali (o la totalità dell'esperienza,
per chi segue lo Zen). Questo saper tacere non è una
semplice regola pragmatica, poiché non è legato a
specifici atti linguistici; è una modalità d'essere che
governa il modo più discreto di porsi verbalmente che
caratterizza i giapponesi. Non si rileva con la pragmatica,
dunque, ma neanche con la linguistica. Infatti, il silenzio
come valore che colora un'intera interazione non è un dato
pertinente per un linguista; non può essere studiato
adeguatamente con gli strumenti della fonologia o della grammatica o
della textlinguistik. Eppure è un attributo del
saper parlare bene in giapponese, che va imparato in un corso di
lingua impostata in un'ottica comunicativo-culturale.[Cliccare
qui> 6]
Le
tre dimensioni teorizzate sono compresenti in ogni atto
comunicativo, come abbiamo già affermato a proposito del
dittongo prolungato calante nel richiamo "Aaaooo, la porta!".
Detto perentoriamente da un romano di borgata, il dittongo comunica
un'inconfondibile modalità d'essere (che può non
corrispondere al modo di essere abituale del parlante – per
esempio, il parlante potrebbe essere una persona colta che "fa
il borgataro" per scherzo). Nel contempo il dittongo
comunica qualcosa anche all'interno delle altre due dimensioni,
quella pragmatica (lo si percepisce come "richiamo") e
quella linguistica (lo si percepisce come "fonosimbolo" o
"interiezione"). Ecco perché lo studio della
lingua viva, quando viene condotto come interiorizzazione
consapevole di un nuovo modo di essere, richiede l'apporto di
un'intera gamma di insegnamenti complementari, dall'etnometodologia
all'ermeneutica.
In
verità concepire le lingue come veicoli di particolari modi di
essere non è nemmeno un'idea nuova. Ne hanno già
parlato Malinowski e Sapir nel Novecento, Humboldt nell'Ottocento,
Vico nel Settecento e via discorrendo. Forse il primo è
stato Aristotele, il quale nella Politica sviluppò il
concetto di "comunità di discorso" (polis).
Tuttavia questa visione del linguaggio è rimasta sempre ai
margini degli studi filologici, glottologi e linguistici
"ufficiali". Ciò che è storicamente
prevalso è stata la visione platonica e poi stoica del
linguaggio come rappresentazione proposizionale, essenzialmente
logico e quindi tautologico, da sottoporre all'analisi formale.
Non solo, ma la visione stoica si è fusa con la pratica del
recupero di testi antichi avviato dai già ricordati grammatici
alessandrini. Ciò significa che lo studio sistematico
dei fenomeni del linguaggio è stato circoscritto per lungo
tempo ai soli dati rilevabili, tramite l'analisi formale, da messaggi
scritti perlopiù antichi. Una visione miope quando si
vuole preparare uno studente ad affrontare i fenomeni della
comunicazione attraverso l'interazione totale in situazioni in
divenire. Ma è la visione storicamente dominante nella
Scuola e nell'Università, concretizzata nel binomio
"grammatica" e "letteratura" che da sempre –
e ancora oggi in larga misura – nega allo studio delle lingue
in quanto vive una sua specificità disciplinare.
Precisata
la giustificazione teorica per l'impostazione dei corsi suggerita
nella terza parte di questo intervento, torniamo dunque al nostro
discorso sulle diverse utenze del Centro Linguistico.
Abbiamo
già detto che la creazione di "filoni" di corsi e di
materiali didattici all'interno di un Centro Linguistico richiede
inevitabili semplificazioni. La didattica è – come
la politica – l'arte del possibile. Poste le restrizioni
dovute al sistema dei crediti ed alle esigenze delle diverse
categorie di utenza, abbiamo proposto che il Centro Linguistico si
limiti ad insegnare le lingue nella loro prima dimensione (quella
della rappresentazione) agli "studenti di scienza" e agli
studenti ad essi assimilabili. Agli "studenti umanisti"
– e giuridico-economico-politici, nonché qualsiasi
studente da qualsiasi facoltà che vuole saper "agire"
in lingua – vanno invece insegnate le lingue sia nella
loro prima che nella loro seconda dimensione (rappresentazione e
azione). Ricordiamo che il concetto di "dimensione"
non implica nessun ordine cronologico o di priorità: agli
studenti umanisti le prime due dimensioni della comunicazione vanno
insegnate contemporaneamente sin dalla prima lezione.
Per
gli studenti di lingue, invece, le lezioni vanno svolte tenendo conto
di tutte e tre le dimensioni – in particolare la terza:
"comunicare per essere" – e ciò sin dalla
prima lezione. Bisogna cioè abituare questi studenti a
concepire la comunicazione linguistica in una situazione
interculturale come essenzialmente un ri-relazionarsi tra diverse
modalità d'essere.
Abbiamo
ribadito più volte che queste lezioni vanno svolte non in un
Centro Linguistico bensì nella sede in cui vengono impartiti
gli insegnamenti complementari con cui esse si intrecciano.
Nulla toglie, però, che questa sede abbia, come un Centro
Linguistico, aule attrezzate per gli audiovisivi e per Internet, con
banchi mobili per la formazione di gruppi di lavoro. Anzi, le
attrezzature tecnologiche sono in un certo senso essenziali.
Come l'aula migliore per un corso di archeologia sarebbe lo scavo, a
cui il docente può supplire in parte con audiovisivi di alta
qualità, l'aula migliore per un corso di lingua viva
sarebbe il paese straniero, a cui il docente può supplire in
parte con un uso oculato di audiovisivi e della telematica. (In
quanto ai cosiddetti laboratori linguistici, gli studenti di lingue
non ne hanno affatto bisogno.) Entrambi questi insegnamenti
infatti – l'insegnamento dell'archeologia e l'insegnamento
delle lingue vive – costituiscono incontri con l'Altro
nella sua specificità materiale non riducibile a noi stessi.
E' pertanto essenziale che più di una traccia di quella
specificità materiale sia presente per dare consistenza alle
parole.
C'è
inoltre un ulteriore parallelo fra l'archeologia e l'insegnamento
delle lingue vive. Entrambi questi insegnamenti cercano infatti
di inculcare una prassi: come dissotterrare un reperto, come
interagire in lingua. Prassi che è sia una riflessione
ermeneutica sull'oggetto, sia un ri-relazionarsi rispetto ad esso.
Entrambe le discipline, dunque, illustrano chiaramente come –
tra un sapere "concettuale" fine a se stesso e un banale
saper fare "tecnico" – esista una terza via.
Chi sa condurre con criterio uno scavo archeologico o chi sa
interagire in lingua in maniera culturalmente convincente, possiede
il sapere che Aristotele chiama phronesis (Etica
nicomachea, VI). E' la capacità di ridefinire la
propria modalità d'essere, di agire e di rappresentare le
cose.
Conclusioni
Tra
un anno, tra tre anni, tra cinque anni sapremo se l'università
avrà finalmente operato quelle trasformazioni necessarie per
assolvere i nuovi compiti formativi nel settore lingue. E lo
sapremo osservando quattro indizi. Sono indizi che chiunque
nella comunità accademica potrà facilmente rilevare –
periodicamente – per valutare fino a che punto l'offerta
formativa in lingue si è effettivamente rinnovata, sul piano
sia locale che nazionale.
Primo indizio: esistono
corsi di laurea imperniati sull'apprendimento delle lingue in
quanto vive? Per sincerarsene basta guardare i
programmi dei docenti dei settori disciplinari denominati
L-LIN. Se, da uno sguardo all'ordine degli studi,
risulta che i programmi di questi docenti mirano a insegnare a
descrivere le lingue e a commentarne gli usi
(letterari), sarà chiaro che non verranno formati futuri
mediatori in lingue. Vorrà dire che la suddivisione
delle cattedre e la creazione di cattedre specifiche di Lingua è
stata usata per duplicare l'offerta, aggiungendo nuovi insegnamenti
descrittivi e letterari a quelli di prima.
Il
secondo indizio da osservare è forse l'indizio più
chiaro di tutti: esistono ancora lettori o "esperti" di
madrelingua straniera, responsabili della formazione degli studenti
del corso di laurea in lingue? Se fra un anno, tre anni o
cinque anni esisterà sempre questa legione straniera di
non-docenti con compiti di docenza, vorrà dire che
l'università avrà deciso di mantenere lo status quo.
Cioè di continuare a reclutare lettori per non dover assegnare
le nuove cattedre a chi (italiano o straniero) si è
specializzato nell'insegnamento delle lingue in quanto vive.
E' ovvio che in questa malaugurata eventualità il problema
linguistico all'università (e nel paese) non sarà stato
affatto risolto. Invece nell'ipotesi migliore, ossia quella di
un'autentica riforma del corso di laurea in lingue, cosa diventeranno
gli attuali lettori? Se un lettore ha i necessari titoli
scientifici e didattici, potrà concorrere per uno dei nuovi
posti di professore di lingua: se non ha i titoli ma ha anni di
servizio, andrebbe collocato in un ruolo ad esaurimento. In
entrambi i casi, le categorie di "lettore" e di "esperto
linguistico", docenti senza lo status di docente e assunti senza
regolare concorso, andrebbero abolite.
Il
terzo indizio: se fra un anno, tre anni o cinque anni le
Scuole di Specializzazione SSIS avranno programmi che, per quanto
riguarda la parte disciplinare, risulteranno simili ai programmi dei
corsi di laurea in lingue (non autenticamente riformati - vedi i
primi due indizi), vorrà dire che l'insegnamento delle
lingue a scuola probabilmente non è migliorato e che il
Centro Linguistico non potrà contare su un'utenza con una base
linguistica già consolidata.
Il quarto ed ultimo indizio: se fra un anno, tre anni, cinque
anni il Centro Linguistico sarà popolato da figure non
docenti -- lettori, borsisti -- capeggiate da un unico professore
ufficiale sorretto da pochi amministrativi (la situazione di
molti Centri Linguistici oggi), vorrà dire che il Centro non
è stato messo in condizione di poter assolvere il compito
di formazione specialistica che, invece, dovrebbe caratterizzarlo.
In questo intervento ho parlato soprattutto dell'alta qualificazione
da richiedere a chi insegna una lingua in quanto viva nei
corsi di laurea in lingue. Ma una qualificazione
ugualmente alta, seppure di diversa natura, la devono avere chi
deciderà gli indirizzi didattici di un Centro Linguistico e
chi li metterà in pratica. I materiali didattici
acquistati o creati dovranno essere idonei per le due categorie di
utenza e per i molteplici genres discorsivi usati nelle varie
facoltà. Inoltre, bisognerà adattare questi
materiali per lo studio individuale. Bisognerà prevedere
prove diagnostiche dei più comuni problemi di apprendimento.
Un Centro Linguistico realmente funzionale deve perciò poter
attingere in maniera strutturale e permanente ad un pool di docenti
provenienti dai Dipartimenti ma facenti capo al Centro, sia per la
creazione dei materiali che per la loro utilizzazione in
aula.[Cliccare qui> 7]
Si
tratta di quattro indizi facilmente rilevabili, dunque, che nei
prossimi anni indicheranno – a chiunque voglia interessarsi –
lo stato di salute di quel grande malato cronico dell'università
italiana che è il sistema di formazione in lingue.
Malato a cui faccio i miei migliori auguri di pronta guarigione.
<<<>>>
Bibliografia
Boylan
P. (2002), "Language as Representation, as Agency, as Being".
In: S. Cormeraie et al. (eds.), Revolutions in consciousness:
local identities, global concerns in Languages and intercultural
communication. CLS - IALIC.Publications, Leeds: Leeds
Metropolitan University, 2002, pp.165-174, ISBN-1-898883-09-2
(disponibile anche in Internet a: www.boylan.it -- cliccare
sulla parola "ricerca").
Byram
M. & Morgan C. (1994), Teaching and learning languages and
culture. Clevedon: Multilingual Matters.
Roberts
C. et al. (a cura di.) (2000), Language
learners as ethnographers.
Clevedon: Multilingual Matters.
Stammerjohann
H. (1996), Lexicon grammaticorum. Tuebingen: Max
Niemeyer.
Pagliaro
A. (1969), Il segno vivente. Torino: ERI. (orig. Napoli,
1952).
Spitzer
L. (1970), Linguistics and Literary History: Essays in
Stylistics. Princeton: Princeton University Press. (orig.
1948).
Turnbull
W. (2001), "An appraisal of pragmatic elicitation techniques for
the social psychological study of talk: The case of request
refusals", Pragmatics,
II/1, 31-61.
Note
[1] Boylan
P. et al., (1983). Documento sui Centri Linguistici; I. La
didattica nei Centri, II. L'organizzazione dei Centri.
Roma: Coordinamento Nazionale Lettori di Lingue Straniere, email:
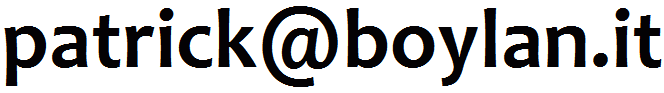 (Versione ridotta per la pubblicazione, 1984). [Tornare
al testo > ● ]
(Versione ridotta per la pubblicazione, 1984). [Tornare
al testo > ● ]
[2] Per una
bibliografia sullo studio delle lingue in quanto vive, vedi
Byram & Moran (1994) e Roberts (2000) nonché i siti
www.ialic.org e, per alcuni esempi pratici, www.boylan.it
(cliccare sulle parole "didattica" e poi
"lezioni"). [Tornare al testo >
● ]
[3] L'inizio dello studio
sistematico dei fatti del linguaggio, per appurare il senso di testi
scritti in una lingua morta o successivamente trasformata, risale
infatti al lavoro dei grammatici alessandrini - iniziato nel III
secolo a.C. - per recuperare il patrimonio letterario greco
attraverso la critica testuale e l'elaborazione sia filologica che
tecnica (e quindi anche sincronica) di un impianto descrittivo del
linguaggio. Vedi la voce "Alessandrini" in Stammerjohann
(1996). [Tornare al testo > ●
]
[4] L'immagine dantesca è
quella usata da Leo Spitzer (1970) per descrivere la comprensione
che rompe il cerchio ermeneutico tramite uno spostamento del
soggetto nel sistema di valori dell'interlocutore, lo stesso atto di
comprensione che compie chi acquisisce una lingua in quanto viva.
[Tornare al testo > ●
]
[5] L'emissione
"Aaaooo, la porta!" funziona come due
richiami se la prima parte viene detta perentoriamente per
attirare l'attenzione sulla porta lasciata aperta; in tal caso
l'aggiunta di "...la porta!" (o di un cenno in direzione
della porta) costituisce una reiterazione della richiesta con
focalizzazione semantica per maggiore chiarezza. L'intonazione
(due toniche invece di una pretonica+tonica) disambigua tra (1.)
richiamo reiterato e (2.) singolo richiamo preceduto da
un'interiezione per attirare l'attenzione. Queste precisazioni
illustrano l'interrelazione tra la linguistica e la pragmatica nel
cercare di capire una qualsiasi comunicazione - a cui bisognerebbe
aggiungere per completezza, però, anche l'etnometodologia,
ovvero la prospettiva esistenziale che verrà discussa più
avanti. [Tornare al testo > ●
]
[6] Per
Turnbull (2001:31) "fraintendiamo" ciò che è
il linguaggio quando lo riduciamo all'espressione scritta (written
talk) e parlata
(talk-as-spoken-language).
Il linguaggio fa parte, nell'uno e l'altro caso, di qualcosa di più
complesso, ossia "talk-as-interaction"
(p. 32): chi studia una lingua straniera, dunque, deve saper
trattare qualsiasi tessuto comunicativo: scritto, parlato, fatto di
soli sguardi o di soli pianti o svolto nel più completo
silenzio ed immobilità. [Tornare al
testo > ● ]
[7] Un possibile
meccanismo di incentivazione potrebbe essere il parere vincolante
del Direttore del Centro per quanto riguarda l'assegnazione, ogni
anno, di una quota dei fondi di ricerca gestiti dai vari
dipartimenti. [Tornare al testo > ●
]
![]() (Versione ridotta per la pubblicazione, 1984). [Tornare
al testo > ● ]
(Versione ridotta per la pubblicazione, 1984). [Tornare
al testo > ● ]